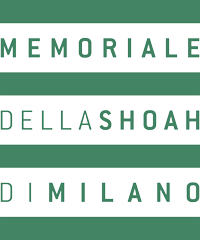Da qualche tempo, due volte al mese, andiamo alla Casa Circondariale di San Vittore per il laboratorio “San Vittore: esperienze di ieri, voci di oggi”. Entriamo da piazza Filangieri, passiamo i controlli, attraversiamo i corridoi, superiamo i cancelli e saliamo al quarto piano del terzo raggio. È lì che si trova “La Nave”, il reparto di trattamento avanzato per le dipendenze attivo dal 2002, gestito dall’équipe dell’ ASST Santi Paolo e Carlo. I detenuti che appartengono a questo reparto affrontano un percorso impegnativo, che rientra in un’ottica di cura e responsabilizzazione: oltre alle regole del sistema penitenziario, aderiscono a un programma terapeutico intenso e strutturato, fatto di incontri e attività, individuali e di gruppo.
San Vittore e la Stazione Centrale – oggi sede del Memoriale della Shoah e della Fondazione CDEC – sono state le ultime tappe delle persone discriminate dal regime nazifascista prima della deportazione. Il progetto lega questi due luoghi mettendo in relazione passato e presente. Quando arriviamo a San Vittore portiamo con noi alcune carte. Non documenti qualsiasi ma testimonianze conservate in Archivio: storie di ebrei e di oppositori politici che tra il 1943 e il 1945 furono rinchiusi proprio tra le mura di San Vittore, nei raggi IV, V e VI. È dalle testimonianze che il laboratorio prende avvio: insieme ai partecipanti leggiamo i testi, inquadriamo il contesto storico, individuiamo i temi che li attraversano. Osserviamo controluce le storie che raccontano per capire in quale modo le esperienze del passato possono parlare al presente. Ci chiediamo che significato possano avere quelle parole oggi, dentro un carcere.
Da questo scambio nascono nuovi testi. Riflessioni, emozioni, ricordi personali e frammenti di vita raccontati in forma scritta dai detenuti del reparto. Nello spazio del laboratorio le carte d’archivio diventano quindi strumenti di confronto, stimoli per ripensare al proprio percorso, occasioni per rielaborare il proprio vissuto e condividerlo con gli altri.
Così, ad esempio, la lettera che Fausto Levi ha scritto alla compagna dopo essere stato arrestato e prima di essere deportato ad Auschwitz, ci porta a parlare del rapporto con l’esterno. Cosa c’è dentro alle prime parole che seguono l’arresto, scritte in una lettera o pronunciate al telefono? Cosa si esprime, cosa si tace? Come cambia nel tempo la comunicazione con il mondo oltre il carcere? Quali motivazioni spingono una persona detenuta a contattare chi sta fuori o, al contrario, a scegliere di non farlo?
Oppure, il gesto di solidarietà nei confronti di un compagno di isolamento che l’oppositore politico Gaetano De Martino ha raccontato nel libro “Dal carcere di San Vittore ai “Lager” tedeschi” apre uno spazio di riflessione sul significato più profondo della solidarietà: che cos’è davvero? Cosa la differenzia dalla stima o dal rispetto? Quali condizioni la ostacolano o la favoriscono? Che forma ha la solidarietà in carcere?
In ciascuno degli incontri abbiamo ascoltato racconti intensi e sinceri, che testimoniano il legame con lo spazio circostante ma soprattutto con quella sfera interiore che ognuno coltiva dentro di sé. I testi condivisi dai partecipanti e gli scambi emersi nel laboratorio hanno sollevato interrogativi, aperto confronti su temi diversi e stimolato riflessioni sulle forme, le dinamiche e i significati dell’esperienza umana; la quale, come suggerisce il nome del reparto “La Nave”, è un viaggio che si compie insieme ad altri.
Bianca Ambrosio, Talia Bidussa, Jasmine Ferrario Sardi, Matteo Lenuzza